CAPITOLO 4
Memorie e segreti

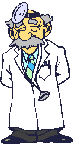
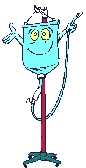
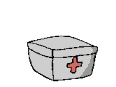
 Ora voglio dolcemente addormentarmi e alla soglia
della terza età rivivere come in un
sogno gli incantesimi dell’infanzia , gli entusiasmi dell’adolescenza e il
disincanto della maturità ,
rincorrendo volti cari di
congiunti ormai scomparsi, antichi maestri
di vita e vecchi compagni di scuola , cercando di fermare sulla carta tutto
quel che vorrà consentirmi la memoria.
Ora voglio dolcemente addormentarmi e alla soglia
della terza età rivivere come in un
sogno gli incantesimi dell’infanzia , gli entusiasmi dell’adolescenza e il
disincanto della maturità ,
rincorrendo volti cari di
congiunti ormai scomparsi, antichi maestri
di vita e vecchi compagni di scuola , cercando di fermare sulla carta tutto
quel che vorrà consentirmi la memoria.
Non pretendo di esaminare fatti e situazioni nel loro svolgimento temporale , ci proverò ma senza troppa convinzione , preferisco raccontarli così come si accavalleranno nel disordinato parapiglia della mia testa.
Spero che a nessuno venga in
mente di svegliarmi proprio adesso.
Quel che avvenne prima della
mia nascita lo so per sentito dire, flashback
di quanto camminavo a quattro zampe non ne ho, i primi evanescenti
ricordi cominciano quando dovevo avere quattro o cinque anni, probabilmente si tratta di momenti dejà vu nascosti nei polverosi
cassetti della memoria assistita in questa difficile ricostruzione da un pizzico di fantasia, sbiaditi filmati
in bianco e nero che scorrono sopra un tapis
roulant d’emozioni e scaturiscono da aneddoti, testimonianze e vecchie
foto.
Proviamo ad intraprendere
insieme questo avvincente viaggio tra cronaca e nostalgia.
E’ l’alba dei favolosi anni
sessanta, comincio a mettere a fuoco,
grazie al primo raccapricciante paio d’occhiali, gli oggetti e i mobili della
casa, a calcolare grosso modo le distanze e ad indovinare, senza correre più
troppi rischi, le luci delle porte che separano la mia stanzetta dalle altre .
Alle 9,07 del 12 aprile 1961
sono ormai un soldo di cacio che parla
decentemente un italiano appena velato da qualche inflessione dialettale e cammina speditamente, finalmente in posizione eretta, lungo i corridoi di piazza Gondar . Con gli
occhietti incerti, strofinando il nasino gocciolante, scruto dal basso il grande appartamento per orientarmi
tra i corridoi e i vani di quella che sarà per me la residenza per i
prossimi vent’anni .
L’ampio ingresso divide la
zona giorno da quella notte, di fronte, chiuso a chiave, il grande salotto con quei comodi divani a
fiori dove non si può entrare, pena il
taglio della testa, da cui si può
accedere tramite una seconda porta allo
studio di papà . Voltando a sinistra si prende il corridoio che costeggia, da un lato il tinello e il piccolo gabinetto
di servizio per poi sfociare in cucina, dall’altro la seconda porta , anche
questa sempre chiusa, della sala da pranzo. Dirigendomi verso sinistra un altro
corridoio, questa volta più lungo,
porta nella mia cameretta lasciandosi sulla destra la camera da letto
dei miei genitori e sulla sinistra il ripostiglio dove mamma ripone valigie e
detersivi . Più avanti incontro la porta principale dello studio , anche qui
vige il divieto d’accesso, proseguo verso
destra , rasento il bagno padronale e chiudo la mia esplorazione di fronte alla porta della camera dei
fratelli più grandi. E’ aperta. Fico! Quanti poster|! Quanti fumetti! Quanti
libri! Quasi quasi entro e faccio un macello tanto Paolo e Piero sono ancora
a scuola.
A quell’ora – quale ? l’ho
appena scritto! Non siete stati abbastanza attenti. Le 9,07 - il primo uomo
mette piede nello spazio ,è il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, diventerà il
primo idolo della mia infanzia , consequenziale sarà la sfrenata passione per
astronavi, galassie e omini verdi.
La domenica mattina può
ancora capitare qualcosa che oggi apparirebbe quasi inconcepibile. Ti
alzi tardi e cerchi con i piedini le pantofole che dovrebbero trovarsi ai piedi
del lettino , dalla cucina arrivano gli aromi delle pietanze che cuociono sui
fornelli, dal bagno il rumore sordo
dell’acqua calda che sta riempiendo la
vasca per sgrassare i gemellini. Ad un tratto ti sembra di avvertire lo stridulo e disperato coccodè
di una gallina provenire dal tinello e attraversare il largo ingresso. Viene
verso di te. Inforchi i pesanti
occhialini di tartaruga e cerchi di mettere a fuoco. Eccola lì! Nel corridoio!
Dietro il grasso pennuto , che invano
cerca di sottrarsi al suo triste destino, arranca trafelata mia madre . E’ animata da un insolito fuoco
sacro, insegue il pranzo con un’
affilata mezzaluna e, tra urla e
schiamazzi, intima alla vittima
designata di fermarsi per essere fatta a pezzi quasi pretendesse una resa senza
condizioni. Sembra di assistere ad un’antica
danza tribale. Mi addosso alla
porta del cesso per non intralciarle la corsa , il vetro smerigliato è appannato dai vapori, la scena è divertente , il carnefice è ormai a ridosso del
disgraziato volatile e brandisce minaccioso il machete, ma non c’ è da preoccuparsi, so già
che quando riuscirà ad acchiapparlo non avrà il coraggio di tirarle il
collo, dovrà occuparsene come al solito , se come spero verrà a pranzo con zio
Gino , la coraggiosa e implacabile zia Maria.
La voce calda di papa
Giovanni arriva rassicurante alle orecchie del suo gregge raccolto in piazza
San Pietro o raggiunge attraverso la radio il resto dei fedeli appartato
nell’intimità del soggiorno arrampicato ai piani alti degli enormi caseggiati
appena innalzati nelle popolose
periferie romane.
Il suo volto affabile appare
sugli oltre due milioni di televisori ormai presenti nelle case e spiazza, con
parole piene di dolcezza e una risoluta apertura verso i problemi
contemporanei, laici, religiosi,
politici e persino i medievali preti picchiapetti
che dicono messa nelle piccola chiesa temporaneamente
allocata in un garage ai confini di viale Somalia.
Il parquet di fronte al televisore è ancora zona a sosta limitata, la
fermata a lattanti come me è consentita soltanto il pomeriggio per la TV dei ragazzi, imperversa l’era dei mutandoni .
Nel nuovo varietà del sabato sera, Studio Uno, le gemelle Kessler, subito censurate, esibiscono gambe
mozzafiato in body e calzamaglia,è il
massimo del softcore consentito ma
basta a solleticare i miei teneri
ormoni in fase di irrefrenabile espansione.
Sui campi di calcio
imperversa l’epopea delle milanesi di Helenio Herrera e Nereo Rocco, degli
scudetti incrociati di nerazzurri e rossoneri e dei mitici incontri di Coppa
dei Campioni , una febbre che inesorabile colpirà anche me: diventerò interista, una breve e cocente infatuazione,
ne parleremo.
Nella rassicurante penombra
della piccola cucina affacciata sul cortile la radio è sempre accesa ,
l’altoparlante trasmette la diabolica
risata del Gambero, temuto ospite
fisso dell’omonima trasmissione radiofonica condotta da Enzo Tortora , o la voce popolare e stridula del mitico
Orazio Pennacchioni impertinente ragazzino dalla lingua biforcuta tifoso
contemporaneamente di Roma e Lazio.
Sulla mensola di formica Susanna e la Mucca Carolina , sui fornelli il sugo per gli spaghetti che cuoce lentamente
diffondendo per la casa uno stuzzicante odore di soffritto, insopprimibile sale
il desiderio, immediata si leva la supplica: “Mamma mi prepari pane e sugo ?”. Cosa c’è di meglio che assaporare
al mattino una bella rosetta intinta in una gustosa salsa di pomodoro fumante?
Devo togliermi dai piedi,
Fernandella deve fare le pulizie prima di uscire con i gemelli a fare la spesa
,i bambini in età scolare sono raddoppiati rispetto a dieci anni prima ma io
non ho ancora l’età giusta per emularli
, non mi resta che traslocare con soldatini e autoblindo nella mia
cameretta, estrarre il tavolino celeste
agganciato alla parete , accostare lo sgabello ed attaccare furente le
postazioni nemiche.
Non vedo l’ora che mamma mi porti con sé sul terrazzo
condominiale, mentre lei stenderà i panni sulla lunga corda tesa tra le due opposte estremità del ballatoio io
apprezzerò il buon profumo di bucato
appena steso che il ponentino diffonderà tutt’intorno.
Tenterò di sollevarmi sulle
punte appoggiando le manine al parapetto per
osservare dall’alto del palazzo le miniature dei passanti e delle
automobili che affollano piazza Gondar e dintorni , poi correrò lungo la lunga teoria di antenne affastellate
sulle spallette e mi porterò sull’altro versante per sbirciare, oltre il ponte
delle valli, il fiume Aniene che costeggia la ferrovia e le baracche dei poveri
ammassate sul greto del fiume .
“Non ti sporgere!” Mi
urlerà come al solito la mamma cercando di non farsi cadere la molletta
sistemata al lato della bocca, braccia tese a sistemare lenzuola capricciose che si agitano ad ogni
alito di vento.
“E chi ci arriva?” considererò sconsolato seguendo la linea
dell’orizzonte .
Oltre il parapetto di destra
s’intravede il contado dello spaventoso fosso di Sant’Agnese, covo di zingari,
delinquenti e ladri di bambini , mi è stato detto di non avvicinarmi mai a
quelle catapecchie se non voglio sparire nel nulla.
E’ tardi. Dal cortile sale
un familiare odore di cavolo , i fratelli stanno per tornare, è ora di tornare a casa ed apparecchiare la
tavola per il pranzo .
“La porto io!”
grido a mia madre strappandole dalle
mani la bacinella vuota , basteranno un
paio d’ore con questo sole così caldo,
poi torneremo in terrazzo a
ritirare il bucato asciutto ed io e mia sorella ci divertiremo
un mondo a nasconderci sotto le
lenzuola distese all’ingresso che mamma tenterà di piegare con l’aiuto di uno dei fratelli più
grandi.
Nel tardo pomeriggio è
prevista la visita dal pediatra, il puntiglioso e zelante Dott. Roberto
Canganella, nel suo studio , al terzo piano di un elegante palazzo di via Nizza
a due passi alla Rinascente, il suo
occhio attento esaminerà al di sotto di quella sua testona calva ogni punto ,
anche il più recondito, del mio tenero
corpicino .
Sarà spietato , mi farà
ingoiare prima quel maledetto cucchiaio , poi m’infilerà nel naso e nelle
orecchie quell’altro attrezzo infernale, non contento peregrinerà lungo schiena e torace con quel fonendoscopio polare per una diligente verifica a cuore e polmoni , infine terminerà quel disumano supplizio con una robusta
martellata sulle mie fragili ginocchia e le tenere piante dei piedini.
Con lo sguardo assorto e
severo farà segno a mia madre ritta in
piedi, intimorita e diligente nel seguire
in religioso silenzio
l’interminabile rito , di
rivestirmi, si alzerà lentamente , girerà attorno al lettino poi sederà , dopo aver sistemato il cuscinetto
sulla sobria poltroncina .
Aperto il cassetto disporrà meticolosamente sulla scrivania una
mezza dozzina di fogli a righe , la matita opportunamente temperata, e il
lapis rosso e blu , infine , in un silenzio sepolcrale, metterà per iscritto la sua dettagliata
anamnesi. Un vero romanzo, venti minuti almeno di indecifrabili appunti,
dettagliate considerazioni e circostanziate note , la mamma nel frattempo
preferirà trasferirsi con le due pesti in sala d’attesa.
Nella stanzetta al di là
della grande vetrata una sediolina a dondolo rosso scarlatto , un pupazzo di
gomma vagamente somigliante a Pinocchio e una mezza dozzina di automobiline
colorate.
Assisterò alla stessa
liturgia respirerò quegli odori e ritroverò quell’imbarazzante atmosfera ,
quando, diciamo vero - citando un
celebre intercalare dell’attempato professionista - quarant’anni dopo, completato
il tris, deciderò di portare l’ultimo nato in visita da quell’infaticabile
specialista.
Il mitico “Canga” ormai ottantasettenne , la mente
ancora lucida lo sguardo sempre vigile , replicherà quei gesti, impugnerà un
identico lapis e comporrà un nuovo
torrenziale referto prescrivendo una miracolosa quanto macchinosa terapia assai
difficile da seguire al giorno d’oggi.
Il tempo sembra essersi
fermato in quel signorile appartamento del quartiere Trieste, tutto è rimasto come allora, nella camera
accanto la vermiglia poltroncina dondola ancora , sparpagliati sul parquet gli
stessi giocattoli .
Una serena fanciullezza
,pochi amici e qualche giocattolo più caro di altri, tra questi mi torna subito in mente un ciondolante
cavalluccio a dondolo trovato la notte della Vigilia sotto l’albero di
Natale rallegrato di luci e colori e
ornato di palle e nastri dorati, innalzato sul parquet della mia stanza .
Allora si allestivano abeti
autentici – il più delle volte gradito omaggio di zio Gino e della forestale -
non volgari imitazioni di plastica
puzzolente , mamma come al solito aveva decorato la casa sistemando il vischio
e i festoni sulle cornici dei quadri appesi all’ingresso , appena un tocco
natalizio sui quadretti accanto al divano nel salotto buono.
I cavalli per me dovevano
essere un vero e proprio chiodo fisso - non avevo ancora scoperto l’altra metà
del cielo - ne disegnavo continuamente, macilenti e in chiaroscuro i primi ,
sempre più paffuti e colorati i successivi, chissà , forse per questa mia antica
passione il primo verso d’animale insegnato al piccolo Alessandro è stato
proprio quello del simpatico ronzino. Quando me ne stavo al calduccio nel mio
letto, vittima di qualche malanno di stagione, ne riempivo blocchi e quaderni.
Amavo molto disegnare e
tutti mi prospettavano un futuro roseo da affermato artista del pennello, non
li deluderò ma d’altra pasta sarà il pennello di cui mi servirò qualche anno
più tardi per deliziare disinibite fanciulle in calore.
Un altro gingillo che
difficilmente scorderò fu uno dei rari doni di nonna Nannina regalatomi nel
giorno della Befana di chissà quale anno.
Mi trovavo nella stanza dei
fratelli, sfogliavo uno di quei sussidiari delle scuole elementari ricco di
colori vivaci e caratteri in neretto che si impiegavano all’epoca per
approfondire i brevi e scarni racconti
dei libri di lettura. Frequentavo probabilmente la prima elementare, succhiavo
un pezzo di carbone dolce trovato nella calza appesa alla cappa della cucina e
nel frattempo osservavo al di là dell'enorme
finestra a parete le nuvole che
lambivano le antenne del palazzo di fronte minacciando pioggia, erano gonfie,
piene come otri e diffondevano nella
camera quell’intenso odore d’acquazzone imminente che sin d’allora mi faceva
impazzire.
Il cielo era ormai color latte quando le prime lacrime cominciarono a tintinnare sui vetri, dapprima lentamente poi sempre più frenetico scendeva finalmente il temporale su Piazza Gondar quasi del tutto deserta dato il giorno di festa.
Fissavo la pioggia trafiggere l’asfalto, era bello vederla precipitare a scrosci e scivolare lentamente per raccogliersi in docili rigagnoli che ruzzolavano sotto i bordi del marciapiede. A volte formava pozzanghere e lì andava a specchiarsi quel po’ di luce che ancora sopravviveva al grigio della giornata invernale, poi riprendeva il suo lento cammino , tornava a far mulinello e con un’ultima piroetta finiva inghiottita dalle grate dell'asfalto bagnato, nero e lucido dove si rifletteva la città.
D’un tratto il campanello
della porta mi riportò alla realtà destandomi da quel piacevole torpore , papà
e la nonna erano entrati nella stanza con un enorme pacco confezionato con un
foglio di carta natalizio rosso agghindato con una fettuccia argentata. Era
proprio per me , strappai eccitato prima il fiocco poi la carta e ai miei occhi
miopi, comunque entusiasti, apparve uno splendido modellino di garage con due
macchinette a carica che scivolavano giù nella rimessa e rombando tornavano
poco dopo in superficie.
L’amico più caro fu però
certamente un tenero orsetto peloso legato al primo ostacolo che la vita mi
piazzò davanti quando ancora l’esistenza era solo gioco e affetti: l’operazione
per rimuovere le tonsille.
Il giorno prima del martirio i miei mi portarono a spasso per
comprarmi un regalo, quasi fosse un risarcimento anticipatamente dovutomi per
l’imminente intervento. Tra le tante vetrine decorate per le feste natalizie lo
scorsi quasi per caso, era un dolcissimo orsacchiotto di peluche, lo ricordo perfettamente come l’avessi ancor oggi tra le
mani, due grandi orecchie marroni , un musetto bianco latte con al centro un
nasone nero, gli occhioni languidi , il pelo morbido color terra di Siena e una
grossa macchia bianca sulla pancia.
Mi sembra di ricordare che
costò parecchio – 3.000 lire mi pare - che all’epoca , correva l’anno 1962 , doveva essere una cifra di tutto
rispetto.
Mi chiesero che nome volessi
dargli.
”Clemente!” esclamai.
Avevo infatti saputo da
pochi giorni che il mio nome completo era Marco Nicola Clemente, scelta di mio
padre il primo, retaggio del mio
misterioso padrino il secondo – il fantomatico avv. Nicola Bonacina
appunto – che non avrò mai più il piacere di rivedere, curioso nomignolo le cui motivazioni ignoro
il terzo.
Lo riposero con cura in
attesa dell’intervento chirurgico ,non vedevo l’ora di abbracciarlo e averlo
con me , compagno prezioso nelle notti scure popolate d’orchi e streghe cattive
che allora mi facevano tanta paura.
La sera dell’operazione ,saranno state le sei del pomeriggio, il cielo era buio e pioveva forte, rivoli d’acqua si formavano sui vetri della finestra accanto al lettino d’ospedale , la pioggia batteva insistente, accanto a me c’erano mamma e Liliana - la fedele domestica - d’un tratto entrò un infermiere, ci chiese di prepararci, mamma fece per accompagnarmi ma fu trattenuta da quell’omone tutto vestito di bianco, per nulla tranquillizzante.
Poco dopo mi trovai dentro
un grande e freddo ascensore interamente rivestito di metallo in compagnia del carnefice e della mia affezionata tata ad ore . Giunti al piano della sala operatoria l’infermierone ordinò alla mia accompagnatrice di fermarsi.
Con gli occhi gonfi e rossi che trattenevano a stento le lacrime cercai lo
sguardo rassicurante della mia ultima amica , incontrai il suo sorriso poi avvertii la mano ruvida
del crudele gendarme nella mia e con il capo chino varcai rassegnato la
soglia della stanza degli orrori.
Alzai lo sguardo , mi
guardai attorno c’era un forte odore di disinfettante ,dava alla gola, poi ,
prima ancora di potermi rendere perfettamente conto di quanto stava per
accadere, mi afferrarono, mi legarono
ad una sediaccia mani e piedi e mentre l’aguzzino mi teneva fermo quel boia del
chirurgo pensò a spalancarmi la bocca infilandomi un ferro in gola e l’altro
nel naso, provai a liberarmi dimenandomi come un forsennato ma fu tutto
inutile.
Probabilmente quel
medicastro quel giorno aveva una gran fretta ma certamente non fece nulla per
incoraggiare quel bambino spaventato, strappò quel che doveva e mi lasciò a
vomitare sangue, poi rivolgendosi all’altro tipastro lo invitò a
riaccompagnarmi in camera.
Rimasi amareggiato per quel
brutale trattamento che proprio non mi aspettavo, ero triste, ma non potevo
proferire parola , fui costretto a tenermi tutto dentro.
Fu la prima esperienza di
vita, compresi da quel giorno che quando ti rode qualcosa è inutile parlarne
con gli altri, meglio inghiottire il rospo , aspettare che ti passi ed
abituarsi a dominare i propri sentimenti.
Ce l’avevo con tutti ed in cima alla lista c’era il mio angelo custode
, me ne avevano parlato tutti tanto
bene suggerendomi di rivolgermi a lui in caso di bisogno e non riuscivo a
capire che fine avesse fatto.
Mamma tentò di consolarmi ma
non volevo nessuno intorno, mi avevano ingannato, lei per prima con tutte
quelle chiacchiere per farmi stare buono , mi avevano raccontato un mucchio di stronzate . Mentire - m'avevano
spiegato - era molto grave per un bambino, un peccato mortale, potete facilmente
immaginare quindi come dovevo sentirmi
io in quel momento , considerato che
a raccontare frottole in questo caso erano stati proprio i grandi.
Aprirono l’armadietto e
tirarono fuori il premio.
Quel povero peluche volò
nella stanza colpito al centro di quell’antipatico muso bianco, da un violento
pugno sferrato con tutta la rabbia che avevo in corpo.
Pian pianino dimenticai
quell’amara giornata , la collera si raffreddò, tra gli scaffali della mia
cameretta, tra soldatini, costruzioni e
camioncini , ritrovai Clemente lo portai con me per qualche notte tentando di
ricucire quel rapporto reciso sul nascere , diventò un amico inseparabile con
cui dividere le gioie e i timori della
fanciullezza.
Qualche anno dopo, quando
ormai grandicello già pensavo alle ragazze e alla musica rock, ricordo che mia madre lo ritrovò sporco e impolverato tra le
cianfrusaglie dello sgabuzzino. Lo regalammo ai bambini poveri insieme ai
vestiti che non ci stavano più e alle scarpe diventate troppo strette, provai
un nodo alla gola,era triste separarsi per sempre da quel simpatico amico
peloso.
Chissà dove sarà ormai?
Probabilmente sarà finito nella spazzatura o dimenticato in qualche soffitta
buia, ma forse, chissà, anche in questo
momento un bimbo spaventato lo stringerà al petto chiedendo a quel musetto
bianco e a quegli occhioni languidi un conforto nelle nottate tenebrose piene
di spaventosi fantasmi e lupi cattivi.
Già quant’erano lunghe le
notti quand’ero piccolo!
Chi pagava lo scotto di
quelle interminabili ore era mio fratello Paolo che nel cuore della notte mi
sentiva scivolare nel suo letto
terrorizzato, comprendeva tuttavia la
mia angoscia e mi lasciava dormire il resto della notte insieme a lui,
in fondo qualche anno prima aveva vissuto quelle stesse paure e aveva chiesto
aiuto a sua volte al primogenito ,
tenendo stretti tra le manine i capelli del paziente fratellone per darsi coraggio.
Aurora m’accompagnava invece al gabinetto, la
chiamavo con un fil di voce ,lesta s’alzava dalla sua brandina e mi prendeva
per mano, non inforcavo neanche gli occhiali, sarebbe stato inutile, mi lasciavo guidare lungo il corridoio che
conduceva al bagno grande, mi restava accanto in attesa che svuotassi l’intero
serbatoio – operazione di un certo impegno già a quei tempi - poi mi riportava
a letto.
Avevo appena nove anni
quando nel 1965 la Rai mandò in onda un fortunato sceneggiato televisivo,
interpretato da un’enigmatica Juliette Gréco , favoleggiava di un terrificante
spettro egizio che vagava di notte per le grandi sale del Louvre avvolta in un manto nero per compiere mostruosi delitti alla
ricerca del tesoro dei Rosacroce , il suo nome era “Belfagor”. Le
inquietanti fattezze in bianco e nero di quella spaventosa maschera , divennero
da allora il peggiore dei miei incubi.
Da poco più di un anno è
uscito nelle sale un remake di quell’agghiacciante
storia con la splendida attrice
francese Sophie Marceau, una fighetta
niente male, nei panni del terribile fantasma . Ci credereste? Non ho ancora
avuto il coraggio di vederlo, quando
entro al videoclub sosto incuriosito di fronte al ripiano dove è
collocato il DVD con la precisa
intenzione di noleggiarlo preso da un incontenibile horreur fascinatrice , prendo in mano il cofanetto, osservo la copertina , scorro la trama del film, poi ripenso a quelle notti insonni e taglio
la corda .
In quel tempo ero io la
femminuccia di casa , i fratelli si divertivano a prendermi in giro cercando di
convincermi che ce l’avevo di gomma importato da Hong Kong, non me la prendevo,
ero il piccolo di casa e mi divertiva tanto averli intorno a fare caciara.
Lella al contrario era esasperata dai crudeli scherzi dei fratelli maggiori, soprattutto quelli orditi dal più grande.
In attesa del pranzo seduti
sulla panca attorno al tavolo del
tinello io e Paolo con il piatto tra le mani fingevamo di guidare scrollando di tanto in tanto la forchetta come fosse il cambio di un'immaginaria automobile, Piero intanto stuzzicava la malcapitata sorellina ,a quel tempo piuttosto
paffuta, soprannominandola Aurora Turina, celebre e adiposa cantante piuttosto
in voga in quegli anni.
Il pianto della poverina
arrivava alle orecchie di mamma che in cucina stava finendo di preparare
il pranzo, ma, al suo arrivo ,Piero come se nulla fosse accaduto assumeva un’aria
innocente e compassata negando qualsiasi addebito , gli altri due maschiacci
dovevano stare al gioco altrimenti sarebbe finito lo spasso.
Povera Lelletta senza di lei
forse oggi non sarei qui a raccontarvi questa storia, quante volte avrà
richiamato l’attenzione di mia madre perché ero salito su un armadio o
penzolavo come una scimmia dal davanzale della finestra?
Cominciarono a chiamarmi il negro, non ne ho mai capito la ragione
precisa, forse perché mi divertivo un
mondo a ciondolare da scale, credenze e ringhiere, o più probabilmente in forza
del fatto che ero piuttosto accomodante
e servizievole . Tra gli altri mio era anche l’ingrato compito di portare la
spazzatura nei grandi cestini di alluminio collocati in quegli anni nel cortile
del palazzo, mansione che eseguo con dedizione tuttora e continuerò probabilmente
a svolgere per il resto dei miei giorni,
anche se al posto di quei
contenitori ci sono oggi i moderni cassonetti piazzati ormai agli angoli delle
strade.
Come arrivava la sera e
s’avvicinava l’ora del rientro di Paolo che era grande e - beato lui - poteva uscire da solo, mi nascondevo sotto i letti o dietro gli
scaffali ed aspettavo che mi venisse a cercare.
Al suo rientro il fratellone
che ormai conosceva le mie bizzarre abitudini frugava dappertutto, sotto le reti, dietro le porte o sopra gli
armadi e quando infine riusciva a scovarmi ridevamo insieme di gusto. Quando
saltuariamente mamma mi lasciava uscire con lui, e soprattutto nelle rare
occasioni in cui era disposto a portarmi con sé, toccavo il cielo con un dito,
andavamo spesso al cinema Boito in via Pietro Mascagni ,con i
biglietti omaggio dono di zio William ,a vedere il più delle volte gli spaghetti western del momento o gli
immortali film d’avventura.
Un pomeriggio dopo aver
assistito alla proiezione de La battaglia
di Alamo con il granitico Jhon
Wayne nelle eroiche vesti di Davy Crockett, tornammo a casa di corsa
incitando i nostri illusori destrieri ad un galoppo forsennato e
schiaffeggiando i nostri fianchi - incauta sella - fino a renderli gonfi e color rosso fuoco con venature di un
verde livido tendenti al nero di seppia.
O quel pomeriggio in cui
Paolo ,novello Guglielmo Tell, nel lanciare le freccette del tiro a segno
intorno alla mia sagoma addossata alla parete della stanza, mi centrò al
fianco!
Giorni felici, spensierati
mentre mamma e papà cercavano faticosamente di far quadrare il magro bilancio
familiare, ma noi non ne sapevamo niente, per noi vivere era solo un gioco
meraviglioso.
Nei primi anni dell’infanzia
giocavo soprattutto con le bambole di Aurora, fenomeno curioso indubbiamente,
ma certamente più insolita era la
circostanza che contemporaneamente la
mia sorellina se la spassasse con le mie pistole! (?) E’ probabile che mentre
si ciondolava nel ventre materno le idee si erano un tantinello confuse e i ruoli
invertiti .
Col tempo tuttavia il mio gagliardo lato maschile prese
il sopravvento e le bambole da coccolare furono altre in carne e ossa - -
particolarmente apprezzata la carne - ma non è il caso di anticiparne ora aspetti e contenuti , la stagione degli amori ,dei foruncoli
e degli ormoni in fermento è ancora lontana.
Passiamo di palo in
frasca - che cazzo vorrà dire ancora me lo devo spiegare, manco mi chiamassi
Tarzan - e torniamo alle festività di
Natale.
Che meraviglia quando arrivavano le feste , quelle vere! Quando la scuola chiudeva per quindici giorni,
il freddo fuori si faceva pungente e ogni tanto villa Chigi si sporcava di
bianco!
Le strade intorno a Piazza
Gondar erano tutte illuminate con ghirlande di stelle comete abbracciate ai lampioni che riflettevano sull’asfalto il loro scintillio e si specchiavano
nelle vetrine decorate dei negozi. Abeti impreziositi da palle luccicanti
ornati con fili oro e argento, colori chiassosi e tanta gente che sciamava per
viale Libia, via Lago Tana e le strade adiacenti.
Non si badava a spese e
l’aria di festa aleggiava intorno a tutte quelle figure intirizzite
raggomitolate nei cappotti e nelle
sciarpe di lana.
Marco bambino non vedeva tra di loro volti stanchi né poteva scorgere indizi di vite disperate o immaginare storie tristi, Natale era solo gioia, allegria, doni da scartare e dolci da divorare.
Tra le calde pareti della
mia stanza, al riparo dal gelido vento di dicembre , le manine appoggiate al
termosifone acceso , al di là dei
vetri appannati dal gelo osservavo
rapito la luccicante insegna di Motta
che troneggiava di fronte ai miei occhi :
una gigantesca “M” fissata sulla facciata del palazzo di
fronte. Enorme! Luminosa! Gioiosa!
Quella lettera era per me il simbolo
stesso delle feste di fine anno, al di
sotto , all’angolo tra piazza Gondar e viale Libia , sui marciapiede
formicolante di gente sfilava
l’interminabile teoria di vetrine
sfavillante di luci e decorazioni
, traboccante di paste, spumanti e
dolciumi del Bar- Pasticceria Motta, assediato , mai come in quei
giorni , da frenetici avventori alla
spasmodica ricerca dell’ultimo regalo di Natale.
La devastante crisi
economica degli anni settanta dapprima ridusse quell’elegante locale ad un modesto esercizio con un paio di
bacheche, qualche anno più tardi lo
fece definitivamente ingoiare dalla solita banca pronta ad impadronirsi dei
loculi lasciati sgombri dai cadaveri
della globalizzazione.
Il profilo di quella monumentale “M” ormai rimossa rimase per anni delineato sull’edificio ,almeno fino a quando i condomini non
decisero di ripulire la facciata, quel giorno quegli spietati operai portarono via con quella mano di vernice insieme a quell’antico emblema anche parte
della mia adolescenza.
In casa Tiddi torroni,
panettoni e pandori non mancavano mai e ancora oggi che papà non c’è più
,ricordo con nostalgia i pacchi dono pieni di leccornie - come le chiamava lui
- che fino a che ci è rimasto accanto ha continuato a regalarci insieme alla
tanto ambita busta di Natale.
La sera della vigilia senza di lui non è più la stessa, ascolti ancora la sua voce divertita che t’implora di non mangiarti tutti i torroni che hai scovato come sempre - nonostante il vano tentativo di nasconderli nei posti più impensati - osservi la sedia vuota attorno al tavolo apparecchiato, avverti ancora la sua presenza sulla poltrona rosa che era la sua cabina di regia durante lo scambio dei regali, ti si chiude lo stomaco mentre un brivido attraversa improvviso la spina dorsale e un nodo alla gola sembra volerti soffocare.
Adesso basta con tutto questo zucchero! Rischio di farvi salire la glicemia per poi costringervi a dosi cavalline d’insulina.
All’epoca in cui papà
lavorava all’Intercontinentale in
occasione della festa dell’epifania la Compagnia distribuiva ai figli dei
dipendenti doni e giocattoli . Particolarmente gradita, da me non certo dai
miei atterriti congiunti , fu la
lussuosa confezione de Il piccolo chimico.
Un infausto pomeriggio
mentre approntavo chissà quale cervellotico esperimento sdraiato sul pavimento
della mia stanza , allora in condominio con la prepotente sorellina ,
versai goffamente dell’alcool sulla mia mano , che, avvicinatasi incautamente alla fiamma del
becco Bunsen , prese immediatamente
fuoco . Bruciava come una torcia, così, spaventato, cominciai ad scuoterla
energicamente, un attimo dopo mi resi conto con vivo stupore che la fiamma
s’era spenta senza lasciare traccia di ustioni.
Compresi immediatamente che
quello non era pane per i miei denti e se è vero che una carriera di
scienziato fu stroncata sul nascere è
pur certo che salvai la pellaccia mia e di chi mi stava accanto evitando
pericolosi, ulteriori “ritorni di fiamma”.
Abbandonate bambole,spazzole
e pettinini cominciai a trastullarmi
con giochi da maschio , prediligevo i minuscoli soldatini dell’Atlantic e le costruzioni Lego .
Gli amici con i quali dividere le ore di svago erano sempre gli stessi : il
rotondo Francesco Giuffrida - mio
compagno di banco alla “Contardo Ferrini” dove frequentavo la scuola elementare
- e mio cugino Fabrizio.
Esisteva però un ostacolo di
non poco conto:i due non si sopportavano anzi si detestavano reciprocamente,
non mi era pertanto possibile frequentarli simultaneamente . Il primo, Franco,
all’epoca dei fatti era un bambinone timido e riflessivo ,l’altro, Scachetta- nomignolo conferitogli
qualche anno più tardi dagli amici del gruppo - era di contro indisponente
e strafottente e si divertiva un mondo
a prendere in giro l’eterno rivale , i litigi, quando si stava insieme, erano
inevitabili.
Che fare? Schiacciato tra l’incudine e il martello non potevo
andare a giocare a casa dell’uno senza che l’altro si offendesse, cercavo di
smorzare i toni , di calmare gli animi ma era tutto inutile. Fu allora che inaugurai
quella saggia filosofia di vita che ancor oggi mi sembra la migliore per
evitare di massacrarsi le palle a forza di smussare gli angoli - il più delle volte quelli degli altri –
che consiglia ”vivi e lascia vivere.”
Resta tuttavia l’incognita che tu potrai pur far vivere gli altri come gli pare
ma non è detto che loro siano disposti a lasciarti campare in pace e grazia di
Dio.
Il mio più caro amico
abitava di fronte casa , al civico 7 della stessa Piazza , dal balcone della
camera da letto dei miei potevo vedere il suo, il telefono era allora
territorio di caccia riservato ai soli
genitori, per parlare tra noi non ci restava altro da fare che affidarci
alle convulse allegorie dell’alfabeto muto.
Non riesco ancora a
capacitarmi di come riuscissi all’epoca ad interpretare i segni del mio
compagno di banco a quella distanza, evidentemente la mia vista era più
acuta , oggi non sarei in grado di
scorgerne la sagoma, probabilmente neppure a distinguere il balcone, forse a
stento individuerei il palazzo.
Il gesto era inequivocabile
,aveva finito i compiti, mi precipitavo
in camera,infilavo le scarpe ,le
allacciavo alla buona - non era il mio forte allora ...né oggi - un cenno di saluto ed ero già fuori casa.
Scendevo le scale a quattro per volta , in un baleno ero al primo piano,
rallentavo prudentemente la corsa perché i gradini si facevano più ravvicinati
e stretti ,ma in fondo recuperavo con un balzo il tempo perduto. Come una
freccia attraversavo l’androne passando di fronte all’attonito Marino - il
solerte e attento portiere dello stabile - un attimo dopo ero sul marciapiede,
uno sguardo a destra uno a sinistra,
come m’aveva insegnato mamma, attraversavo la strada e m’infilavo nel portone
di fronte.
Il gioco preferito in compagnia di Franco era quello del calcio
adattato a quelle che erano le dimensioni
della stanzetta che fungeva da campo di gioco , ovviamente anche le
regole non erano esattamente le stesse. Piazzavamo le poltrone verde
smeraldo,ai due angoli opposti della camera a guisa di porta ,ci disponevamo
nel mezzo e appallottolato un giornale o talvolta un paio di calzerotti - il
più delle volte puliti ma non
necessariamente - cominciavamo
l’incontro.
Scopo del gioco era quello di far rotolare quella palla così arrangiata sulla poltrona alle spalle dell’avversario colpendola con le mani, mai più di una volta. La partita finiva quando la carta era irrimediabilmente sfilacciata o il mio amico, ansimante, grondava sudore come una fontana, la madre in questo secondo caso si catapultava nella stanza come una furia - battendo immancabilmente le ginocchia contro la poltrona - e nel vano tentativo di strapparci l’involucro maledetto cominciava ad imprecare come un camionista curdo sorpassato in curva sotto un tunnel.
Quando il clima lo consentiva
e soprattutto quando l’arzilla zia Rosa – affabile sorella dello scontroso papà
di Franco - veniva a trovare il mio amico era per noi giorno di festa,la simpatica vecchina ci portava infatti a
giocare a Villa Chigi con un pallone vero , sia pure un Supertele da due soldi , dietro al quale correvamo tutto il
pomeriggio fino a stramazzare stremati a terra.
L’amico del cuore tuttavia
aveva un rilevante difetto,era un secchione da paura, il dieci in tutte le
materie era prassi consolidata e l’inevitabile confronto era sempre dietro
l’angolo quando mia madre controllava i miei voti ed esaminava con i miei
insegnanti il mio rendimento scolastico.
Il sei stracciato era il
voto massimo che riuscivo ad ottenere sin dalle elementari dalle mie instabili
meningi, senza dubbio poco inclini allo studio e certamente più attratte da intrattenimenti ludici di vario genere.
Piuttosto che dedicarmi a barbosi libri di testo preferivo infatti
dilapidare quel po’ di vista che mi
rimaneva nella peccaminosa visione di riviste per soli adulti – le ore, caballero o Man le più
gettonate - utili, ma non
indispensabili , per certe mie esercitazioni manuali tipiche dell’età puberale.
Nell’intimità del confessionale , al quale mi avvicinavo
periodicamente reo confesso , Don Nello , informato delle mie turpi
abitudini, mi aveva più volte
rimproverato profetizzandomi la dannazione del fuoco eterno per essere incappato in un simile peccato mortale , nonostante la gravità del crimine , me l’ero comunque
sempre cavata con una decina di Ave Maria e altrettanti Padre Nostro. Più preoccupante di contro quanto sosteneva la mamma che
propendeva per l’ipotesi di un concreto rischio di progressiva e irreversibile
cecità nel caso di reiterazione dolosa del reato di “manovella”.
Evidentemente ,visti i
risultati, aveva ragione quest’ultima.
Per farla breve insomma me
piaceva da gioca’, collezziona’ figurine de’ carciatori e guarda’ le donne
nude!
Un particolare articolo di
cartoleria invidiavo comunque al mio erudito amico, quegli eleganti quaderni a
spirale da cui si potevano agevolmente staccare i fogli a righe o a quadretti
da scarabocchiare. Purtroppo mia madre non me li volle mai comprare, forse
perché ero solito riportare a casa da scuola solo le copertine - falcidiate da
pieghe e ghirigori - dei “normali”
quaderni “Pigna”.
Durante le interminabili ore
di lezione la mia mano svelta tracciava
sulle pagine, malamente stracciate dal
quaderno, cruente battaglie di terra, di cielo e di mare. Disegnavo centinaia di minuscoli soldatini che
da un fronte all’altro della pagina si sparacchiavano
contro schizzi d’inchiostro, le traiettorie dei colpi tratteggiati a penna bic attraversavano il foglio centrando
l’eroico fante che ,colpito a morte, veniva frettolosamente cancellato da un
getto più denso d’inchiostro rosso. Dopo un’epica lotta il foglio di carta si
trasformava in un immenso cimitero di scarabocchi, segnacci ,linee dritte,
curve e gomitoli d’inchiostro trascinati in una densa spirale che svaniva in un
buco nero : un foro al centro della pagina dove tutto spariva in una baraonda
infernale.
Gli incontri di calcio virtuali formato foglio protocollo
seguivano più o meno le medesime direttive. Una volta tratteggiato il
rettangolo di gioco delimitato dalle
linee bianche , definite le aree di rigore e il cerchio di centrocampo
,comparivano uno ad uno - abbozzati con tanto di maglietta calzoncini
calzerotti e numerino - i ventidue giocatori che prendevano a calciare un
puntino d’inchiostro, diretti da un bacarozzetto
nero e dai suoi assistenti disposti ai margini del foglio e incitati da
un folto e rumoroso pubblico schierato sulle tribune , munito di striscioni e
bandierine che garrivano al vento. Non mancava nulla, persino gli sponsor e i
fotografi a bordo campo trovavano posto su quel pezzo di carta a quadretti.
La domenica ero spesso
ospite del mio paffuto compagno di banco nella casa di campagna che i genitori
possedevano nei pressi di Zagarolo, la
cosiddetta Vigna , e lì ce la
spassavamo alla grande in compagnia
della piccola Melina, la sorella minore segretamente innamorata del
sottoscritto , organizzando
improvvisate gare di atletica, interminabili partite a pallone ed allegre corse
a perdifiato lungo i saliscendi degli aridi terreni circostanti.
Qualche anno dopo tornammo
alla Vigna per stillare il vino, con noi l’amico Mauro, bevute colossali, danze
tribali a piedi scalzi nei tini colmi
d’uva e , a sera, prima di prender
sonno, leggendarie gare di scureggie nella piccola stanza da letto al piano
rialzato trasformata in pochi istanti in una micidiale camera a gas.
Certamente non era difficile
divertirmi con Franco, amavamo più o meno gli stessi giochi, più complicato
invece trovare un punto d’incontro ludico con Fabrizio a cui piacevano i
trenini elettrici...a me i soldatini...non restava che trasbordarli tutti sui
vagoni e avviarli verso l’eroico e fatale combattimento che li aspettava lungo
il percorso oltre la galleria di cartapesta.
Gioco divertente, non lo nego, tuttavia il nostro trastullo
preferito era quello di far arrabbiare Flora, la “tata” della numerosa prole
che stanziava, anzi, sciamava nell’appartamento di via Maestro Gaetano Capocci
diventata, nel frattempo, la dimora di zio William e zia Nanda.
Quando quest’ultima,
improvvida, usciva trafugavamo il pallone di cuoio dallo stanzino e
cominciavamo a giocare in cucina. Io dovevo centrare un’anta dell’armadio a
muro dietro di lui mentre il cuginastro tentava di “segnare” colpendo la porta del bagno di servizio alle mie spalle
che percossa da violente pallonate gemeva pericolosamente sui cardini.
Vano era il penoso tentativo della povera Flora di farci smettere minacciando un particolareggiato resoconto dei nostri misfatti a chi di dovere, inutile il suo prodigarsi nel provare a strapparci la sfera assassina in un pandemonio di colorite imprecazioni,urla disumane e colpi sordi contro le incaute e improvvisate porte da calcio.
Le figurine! Le Grandi raccolte per la gioventù! Che spasso collezionare quelle dei calciatori, degli assi dello sport ma soprattutto quelle dedicate al Rinascimento dell’album “I Secoli d’oro”.
Ricordo come in un fermo
immagine quando papà mi regalò quello splendido album colorato della Panini, in copertina campeggiava l’eroica figura di un prode
cavaliere protetto da una luccicante armatura in sella ad un magnifico
destriero ornato con preziosi e policromi finimenti.
Eravamo andati, come
accadeva di sovente la domenica - il traffico era scarso - ad incontrare
qualche cliente in una borgata periferica colonizzata a suo tempo da un nutrito
gruppo di emigranti pagliaresi, tra la via Collatina e il Grande Raccordo
Anulare, nota come La Rustica . Arrestò l'auto come di consueto accanto all'edicola
per acquistare il giornale , d’un tratto incontrò con il suo sguardo i miei
occhi nascosti dalle spesse lenti che osservavano incantati l’album appeso con
una molletta alla tettoia del chiosco, ero immobile la bocca socchiusa in un espressione di stupore, la manina sudata racchiusa nella sua. Infilò
il quotidiano sotto il braccio mi sistemò tra le sue gambe per liberare la mano
ed estrasse di nuovo il portafoglio dalla giacca, poco dopo stringevo felice
l’album nella mano mentre una decina di pacchetti di figurine facevano capolino
dalla tasca del mio cappottino.
Quei paesaggi da fiaba
popolati da maghi, streghe , re e valorosi paladini che combattevano su prati erbosi nei pressi di leggendari
castelli eccitarono la mia fantasia suscitando in me la smodata passione che da
allora provo per la storia.
Purtroppo a Fabrizio la mia
collezione piaceva poco per lui esistevano soltanto i calciatori e i campioni
dello sport.
Quando giocavamo a soffietto o a pari e dispari per vincere le figurine mancanti con i compagni di
scuola , mi affidavo di regola alla sua abilità, io ero una vera frana ed ogni
volta che tentavo la fortuna perdevo immancabilmente grappoli di doppioni raccolti nel tradizionale
mazzetto immobilizzato dall’elasticone verde.
La figurina di un giocatore difficile da trovare in quell’epoca era quella di Pascutti, centrocampista del favoloso Bologna anni ‘60, quando finalmente riuscii a snidarla nell’ennesima bustina completai l'album finalmente gonfio di figurine e coccoina , a quel punto però i giochi erano fatti , non restava che aspettare l’inizio del campionato successivo.
Era il magico momento della
grande Inter di Helenio Herrera e lo
squadrone nerazzurro trionfava in Italia ed Europa con la mitica formazione:
Sarti, Burnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Bertini, Mazzola, Suarez, Corso e Jair .
Un tardo pomeriggio ,
durante un furioso temporale di una delle tante domeniche trascorse in casa a
guardare la televisione, seguii la
sintesi di una loro partita , fu amore a prima vista.
Quando la mia squadra
giocava a Roma contro la Lazio zio William, scalmanato tifoso biancazzurro, mi
portava con sé allo Stadio, quei minuscoli omini che correvano dietro a un
pallone invisibile ai miei occhi mi
procuravano però solo vertigini e un forte mal di testa.
Quella che credevo
un’incrollabile fede durò fino ai primi anni ottanta quando,dopo lo stallo
degli anni settanta nei quali a tutto pensavo tranne che al calcio, incontrai
il vero amore e il mio tifo si colorò di giallorosso.
La domenica mattina mi
recavo spesso con papà al Totocalcio a trovare il fratello, l’instancabile e
leggendario Rag.. Era una pacchia!
Lo zio William – Wigliuccio per i nipoti - mi regalava
sempre matite,pennarelli e block notes su cui disegnare o attaccare i doppioni scampati allo sterminio del pari e dispari . I lunghi corridoi e gli
ampi stanzoni di largo Maresciallo Diaz 13 diventarono ben presto familiari ,
qualche anno dopo cominciai a lavorare lì come ausiliario guadagnando i primi
quattrini per acquistare i miei dischi preferiti, ma questa è un’altra storia.
Con l’aiuto di Fabrizio
scrissi il mio primo libro ,lo
intitolai Il librone, era un grande blocco
quadrato con centinaia di pagine,
copertina in finta pelle rosso fiamma; incollai su quei fogli figurine
d’ogni specie,calciatori,dinosauri,animali e piante, il tutto diviso per
categorie ,accanto ad ognuna una breve didascalia .
La domenica e i giorni di
festa ci recavamo spesso in via
Cartagine – zona Quadraro - a far
visita a zia Maria, la remissiva
sorella di mia madre ed insieme
trascorrevamo piacevolmente il
pomeriggio guardando in Tivù Quelli della
Domenica , la popolare trasmissione
domenicale di varietà condotta da
Raffaele Pisu con la partecipazione di Paolo Villaggio nei panni del teutonico
professor Franz Kranz e di Cochi e
Renato all’ esordio televisivo , poi , mentre le sorelle conversavano amabilmente di guai e parenti , ci
occupavamo di far sparire le paste acquistate prima di partire da Marinari e seguivamo la consueta sintesi
di una partita del campionato di calcio trasmessa nel tardo pomeriggio ,
infine, soddisfatti, ce ne tornavamo
allegramente a casa. Non di rado però, soprattutto nel periodo estivo o durante
le vacanze di fine anno, mi capitava di restare da lei per il fine settimana.
Mi pare di ricordare che
all’epoca fosse già vedova non ricordo infatti la presenza in casa di zio Gino
, rammento però con chiarezza gli splendidi blocchi di carta a rotolo dono delle ferrovie dello Stato che
quest'ultimo mi regalava, conoscendo la mia passione per il disegno, quando
andavamo a trovarlo.
Zio Gino morì
presto,echeggiano ancora nella mia mente le parole di conforto che mamma ebbe
per la sorella quel triste pomeriggio nel quale dopo la scomparsa dello zio,
venne a trascorrere qualche giorno da noi.
Capabianca , come affettuosamente la chiamavamo a causa della sua precoce canizie
, da allora rimase spesso con noi -
Lello era già sposato e Mimmi stava per imitarlo . Era la donna più buona e generosa che io abbia mai conosciuto
,univa alla venerazione per la sorella un sincero amore per noi nipoti.
Sicuramente in Paradiso
ascolta ogni nostro pensiero e segue ogni nostra azione pronta ad aiutarci
, a lei di certo indirizzerei la mia preghiera qualora ne avessi
bisogno,sempre disponibile mai stanca di porgere aiuto, incapace di voler male, di pronunciare una parola fuori posto
o anche di meditare un solo cattivo pensiero.
Tanti anni dopo, poco prima
della sua morte, andai a trovarla alla
clinica dell’Addolorata all’interno
dell’ospedale San Giovanni, era ormai svanita, lo sguardo perso nel vuoto, le
labbra secche e tremanti, non mi riconobbe, provai un tuffo al cuore . Le
rimasi accanto stringendo commosso
quella mano scarna e gelida che tante volte aveva carezzato i miei capelli
tessendone le lodi, anche allora su quelle gracili spalle l’eterno golfino di
lana nero che non dimenticava d’infilare
neanche in pieno ferragosto.
Qualche volta Maurizio detto
Mimmi , il figlio minore, mi portava
con sé in una fumosa saletta di seconda visione, sistemata in una via
adiacente, ad assistere alla proiezione di polverosi film western con carovane
di pionieri in viaggio verso terre vergini e drammatici assalti alla diligenza.
In compagnia della zia
invece salivo spesso al piano superiore da una vicina che aveva due
figli più o meno della mia età, fu in quel piccolo appartamento che in un freddo
pomeriggio di fine dicembre accadde
l’irreparabile.
Ero il più grande tra i quattro o cinque diavoli che si erano
riuniti a casa della signora Avitabile per festeggiare il compleanno di uno dei
suoi ragazzi, la zia dopo avermi accompagnato era tornata nel suo appartamento
, d’un tratto avvertii delle fitte lancinanti al basso ventre : tanto
inaspettata quanto inopportuna s’era preparata sulla rampa di lancio una fitocca da primato, qualcosa di
mostruoso, mi scappava da matti!
Non riuscivo più a trattenerla,
stavo già per tornarmene al piano di sotto per espletare le ormai improcrastinabili funzioni fisiologiche, quando un’impaziente
“stronzetto” - di nome e di fatto -
scivolò lungo i pantaloncini corti
adagiandosi senza far rumore sul tappeto buono dell’ingresso.
Naturalmente feci finta di niente e continuai a giocare con i miei amici come
se niente fosse , sapevo tuttavia che
il ritrovamento del maleodorante batuffolo era solo questione di tempo.
Pochi minuti dopo infatti , puntuale,
la raccapricciante scoperta , la padrona di casa , sconvolta, era
impallidita alla vista del corpo del reato .
Durante la scrupolosa
indagine prontamente istruita per
scoprire il sordido responsabile di una tale disgustosa nefandezza, nella
spasmodica ricerca di prove inoppugnabili e delle inconfondibili tracce di
“polvere da sparo” lasciate dall’inconsueta “arma del delitto” sugli indumenti
intimi dei presenti, fu ordinato agli ovvi
indiziati di calarsi le braghe.
Me ne stavo lì tremante ,
inorridito all’idea dell’inevitabile figuraccia che ne sarebbe derivata ,quando accadde ,insperato, il miracolo:
“Marco tu vai pure! .La zia t’aspetta. Non puoi essere stato certo tu
che sei il più grandicello!” sentenziò l'amabile padrona di casa.
“Sì…Signora, certo…” balbettai incredulo “Arrivederci”.
In un lampo sgattaiolai
fuori dal luogo del delitto e , scese di corsa le scale che portavano al
pianerottolo del piano inferiore, suonai freneticamente il campanello della
porta dell’appartamento di zia Maria.
Salvo! Ma che paura!
Anche con Paolo,complice
l’età, mi divertivo un mondo a giocare, ritagliavamo dal “Corriere dei Piccoli”
le figurine dei ciclisti pubblicate nell’ultima pagina di copertina,
attaccavamo le silhouette ad un cartoncino opportunamente sagomato per renderle
rigide e piegata la base già predisposta li facevamo avanzare a colpi di dadi
sulle liste del parquet della stanza di Aurora . Gimondi, Adorni, Bitossi
Taccone ed Anquetil correvano sul pavimento verso il traguardo collocato al
bordo della porta finestra che portava in balcone, verso l’immancabile vittoria
della corsa rosa e la gloria imperitura!
Quando era ora di uscire
però mio fratello aveva ben poca voglia di portarmi con sé, inutile zavorra se
si trattava di compiere qualche bricconeria e terzo incomodo nel caso di un
fortunato incontro con qualche bella ragazza. Soltanto quando andava a giocare
a calcio sul campo dell’oratorio aveva pietà ,ma si limitava a piazzarmi dietro
la porta ad osservare i grandi
giocare con la speranza che ogni tanto la palla finisse fuori per andare
a riprenderla.
Proprio su quel terreno di
gioco una domenica mattina afferrai al volo insieme a qualche palla calciata
malamente fuori bersaglio la prima parolaccia.
Arrivato a casa attesi
pazientemente la prima occasione utile per ripeterla poi, mentre pranzavamo, approfittando di un
maldestro movimento con il gomito contro la brocca e del conseguente
spargimento di almeno mezzo litro d’acqua sulla tovaglia pulita - situazione
assai ricorrente - sparai un
monumentale “Rimortangolieri”! Si
trattava in fondo di un innocuo sinonimo - per di più edulcorato –
della triviale espressione dialettale “Li
mortacci !”, ma tanto bastò. L’ardire mi fu fatale, riuscii appena a percepire la folata di vento provocata dall’avvicinarsi del sonoro sganassone in arrivo, ma quando tentai di scansarmi era già troppo
tardi , una sventola formato autotreno mi aveva investito in pieno colorando di
un acceso rosso porpora il mio sfortunato orecchio destro, la terrificante onda
d’urto prodotta – pari al sesto grado della scala Mercalli – mi aveva praticamente disintegrato il timpano.
Lo sguardo di papà che mi
fissava piuttosto incazzato , ma
forse già pentito di quel gesto inconsulto,
mi rese chiara la situazione, sarebbe stato meglio per me dimenticare
quella colorita imprecazione . Avevo capito la lezione: evitare ad ogni costo il turpiloquio e ,se
proprio necessario, scegliere un luogo lontano, dove mio padre non poteva
sentire e attendere il momento giusto.
L’avvocato comunque raramente
s’azzardò a metterci le mani addosso, ricordo solo un paio di episodi, quello
appena raccontato ed un altro, molto più in là nel tempo, che mi ferì
profondamente e del quale non ho voglia di parlare.
Chi invece era un po’ più dura nei nostri confronti era la mamma.
A dire il vero io ne presi pochine , ero piuttosto fessacchiotto , non mi piaceva fare
arrabbiare nessuno e, se sorvoliamo
sulla consolidata abitudine ad arrampicarmi dappertutto e oscillare dagli
armadi come uno scimpanzé, non rompevo troppo i coglioni. I fondoschiena di Piero ed Aurora al contrario ve ne
potrebbero raccontare delle belle , bersagliati, a torto e a ragione, dall’ira funesta di Fernandella
indispettita dalla strafottenza dei
due.
Così va il mondo,beccati col
sorcio in bocca nel fottersi qualche cento lire dal borsellino e sordi ai
rimproveri di mamma Nanda , preferirono buscarsi una vagonata di ceffoni
piuttosto che rinunciare a quella loro scriteriata abitudine , niente di serio
beninteso,ma quando tua madre continua a ripeterti “Meglio in galera che ladro” dovresti riflettere meglio sulle
conseguenze delle tue azioni.
La sfiduciata vittima per
sfuggire alle morbose attenzioni dei due monelli verso il Dio denaro era
costretta a nascondere i soldi nei posti più impensati fino a dimenticarne
l’ubicazione Ella stessa, accadde così che, quando sparirono la bellezza di
cinquemila lire, i sospetti s’indirizzarono fatalmente verso il povero Piero.
Questi giurò e spergiurò
dichiarandosi estraneo alla faccenda e professando invano la propria
rettitudine , solo quando
misericordiosa la lavatrice restituì insieme al bucato la famigerata banconota,
venne provata alfine la sua innocenza.
Anch’io un giorno ne beccai
tante. Gran coglione a quei tempi.
Mamma era scesa un istante
al piano di sotto dalla signora Sbrana lasciandoci soli non prima d’averci
sciorinato la solita ramanzina e le
raccomandazioni di turno. Aurora, non so come, fece cadere i candelabri che
ancora oggi ornano la consolle dell’ingresso, ammaccandoli irreparabilmente, si
mise le mani nei capelli e in lacrime mi chiese disperata di accollarmi la
colpa del tragico evento, rimasi perplesso invero, ma non abbastanza, se è vero
come è vero che al ritorno dell’inviperita genitrice che osservava con
raccapriccio i candelabri agonizzanti a terra,confessai a capo chino la piena
responsabilità dei fatti.
Che confusione sto facendo!
Rischio di non farVi capire
più un tubo, ma che importa?
Forse tra una ventina d’anni
i miei figli leggeranno il messaggio di una vita affidato alla bottiglia dei
ricordi e conosceranno un po’ meglio questo loro padre noioso e brontolone che
deve sempre dirgli cosa fare e cosa non fare , cosa dire e cosa non dire. ”Vu!
Vu!” mi chiamano ed hanno ragione , il solito antico rituale dell’esistenza
si ripete ciclicamente. anche l’uomo più moderno apparirà sempre “vecchio” a
chi gli succederà. “Sono un minorenne
anziano” diceva il grande Totò.
Come potrei dimenticare il
primo giorno di scuola?
Scendemmo in strada di buon
mattino,ma prima papà immortalò l'avvenimento con una serie di foto sul balcone
del salotto.
Aurora impeccabile nel suo grembiulino bianco , fiocco azzurro
e gonnellino corto, il sottoscritto
pareva il suo negativo, grembiule celeste, fiocco bianco malamente
annodato, pantaloncini a giro collo ed un noiosissimo colletto rigido, che
impediva il libero movimento della
testa e con un fastidioso sfrigolio causava
dolorosissime ustioni al tenero collo di un povero bambino già piuttosto
stranito per l’alzataccia e la costrizione ad un’anomala strigliata a
fondo per la speciale occasione.
Dopo il dettagliato servizio
fotografico ci mettemmo sulle spalle le cartelle nuove fiammanti nelle quali
mamma aveva infilato la merenda per la ricreazione e montammo in auto con i
nostri genitori verso la nuova avventura.
La scuola m’apparve subito
sinistra, un cupo istituto religioso, un agghiacciante edificio popolato da figure inquietanti,nere come la
morte.
Varcata col batticuore la
soglia dell’aula la prima sensazione fu
di autentico terrore! Quei corvacci che giravano per i corridoi sempre due a
due come i carabinieri mi mettevano
addosso una paura d’inferno.
Il buon giorno si vide dal mattino.
Pochi giorni dopo le arcigne
insegnanti rconvocarono i miei e senza inutili preamboli comunicarono la dura ma
inevitabile sentenza ,la femminuccia avrebbe potuto proseguire gli studi ma per
me “non era cosa”.
La decisione non mi
dispiaceva , anzi , ma che esagerazione!
In fondo la ragguardevole
quantità d’inchiostro applicata diligentemente in ugual misura su ambedue
le mani , su quell’odioso collare bianco e sul grembiulino celeste , i
gessetti spalmati nelle tasche scucite o il fiocco che penzolava fino a
trascinarsi sotto le scarpe slacciate,non potevano giustificare il mio
prematuro allontanamento a scopo precauzionale dall’Istituto, ero un buon
elemento in fondo ,un bravo e rispettoso scolaro ma avevo solo cinque anni,come
potevo farmi capire da quelle antipatiche suore? Oltretutto inglesi!
L’anno seguente constatata
la mia evidente insofferenza per una formazione scolastica di tipo religioso, i
miei optarono per l’iscrizione ad un istituto d’istruzione pubblica ,la scuola
elementare “Contardo Ferrini”.
Docenti più comprensivi e meno esigenti sostituirono le spaventose monache anglosassoni, il profitto scolastico non mutò granché ma l’approccio con la scuola fu meno devastante per la mia fragile personalità, per dirla tutta , in sostanza , se la voglia di studiare restava pochina il nuovo ambiente si presentava perlomeno un po’ più confortevole.
L’aula scolastica conservava
lo sgradevole odore di gesso e
l’aspetto spettrale della precedente , ma se non altro quel grande giardino
esterno rendeva meno desolante la
prospettiva di proseguire gli studi per cinque lunghissimi anni.
All’uscita poi m’aspettava, ben ritagliato e opportunamente incollato
all’angolo tra via Valnerina e via di Villa Chigi , l’omino delle olive e dei lupini con i suoi cesti pieni d’ogni
grazia di Dio , sopra la sua figura immobile
svettava il denso fogliame della misteriosa parte ancora chiusa al
pubblico del parco, attorno , proveniente dalla stessa villa , quel
caratteristico odore d’erba falciata.
Nel laboratorio di musica
imparai a riconoscere i simboli musicali grazie all’ingombrante idrofono , una fila di sette bottiglie poste
l’una accanto all’altra , ognuna con la giusta quantità d’acqua , che
carezzate da un colpetto di cucchiaino emettevano il suono argentino di una
determinata nota . Ero un vero maestro
, lo testimonia l’ottimo voto in
disegno, recitazione e canto, unico otto
in una selva intricata di sei
stiracchiati, se si sorvola sul sette
in attività manuali e pratiche – che non sono quelle che potreste pensare voi –
e sull’ormai rituale nove in condotta.
La maestra Buscemi m’insegnò durante i primi due anni a tenere decentemente in mano una penna mostrandomi la differenza tra questa e una vanga , a disegnare le prime stanghette, a scrivere le prime vocali e a balbettare le prime elementari frasi sui libri di testo.
Trascorrevo lunghe ore a braccia conserte all’interno della grande aula affacciata su Villa Chigi , ora ascoltando barbose lezioni, ora esercitandomi a scrivere e far di conto , con la segreta speranza di poter uscire di tanto in tanto con i miei compagni per giocare a ruba bandiera o ai quattro cantoni tra gli alti pini del boschetto della scuola.
L’anno successivo venimmo affidati al laconico maestro Favara, originale archetipo d’insegnante. Arrivava con la sua Dauphine grigio topo ed appena entrato in aula disponeva diligentemente sulla cattedra la sua borsa di pelle, ne estraeva con un minuzioso cerimoniale il quotidiano ed un sacchetto con un paio di cornetti, effettuato l’appello ordinava al capoclasse - ovviamente interpretato da Franco - di scrivere alcune frasi alla lavagna. Il nostro compito era quello di scomporle in sillabe, poi stendeva il giornale sulla cattedra apriva il cartoccio e cominciava a leggere e a divorare quei croccanti croissant. Immancabilmente ogni giorno finiva per appisolarsi fino a sprofondare in un sonno profondo , solo il molesto suono della campanella che annunciava la ricreazione lo scuoteva da quel tranquillo letargo.
In quinta elementare si
presentò in classe il maestro Pomponi che con infinita pazienza e lodevole
abnegazione tentò d’insegnarmi i primi essenziali rudimenti d’aritmetica senza
peraltro mai riuscirci.
Io e l’ostica materia
iniziammo una singolare gara dalla quale uscii fatalmente sconfitto e con le
ossa rotte , da allora continuammo a
litigare non arrivando mai ad un onorevole trattato di pace se è vero come è tristemente vero che ,alla
veneranda età di quarantasei anni, non sono ancora in grado di risolvere una
divisione a due cifre. Non parliamo delle virgole poi che sono per me oggetti
non meglio identificati che galleggiano negli spazi siderali di quello
sconfinato e incomprensibile buco nero che ha le orribili fattezze
della matematica.
La votazione ottenuta
nell’anno scolastico 1967/68, presso la
scuola Contardo Ferrini di via di Villa Chigi 22 , al conseguimento della
licenza di quinta elementare mostra chiaramente quale poteva essere il mio
profitto all’epoca:
|
Religione |
Sette |
|
Comportamento ed educazione morale e
civile |
Nove |
|
Educazione fisica |
Sei |
|
Lingua straniera |
Sei |
|
Aritmetica |
Sei |
|
Geometria |
Sei |
|
Storia e Geografia |
Sei |
|
Scienze |
Sei |
|
Disegno recitazione e canto |
Otto |
|
Attività manuali e pratiche |
Sette |
La scuola comunque non era
solo l’ apprensione per gli
scappellotti del maestro Favara e l’incubo delle quattro operazioni,era
anche l’occasione per uscire più spesso di casa e per conoscere nuovi amici
come Ruggeri e Ravaioli , caratteristici esemplari di homo secchione, in grado di allungare la lingua dal primo banco
fino a lambire la cattedra, il commovente Coco che prima di entrare in aula
doveva aiutare il padre nel lavoro e finiva inevitabilmente per addormentarsi
in classe – roba da libro cuore – il prepotente Filosa, il primo con cui venni alle mani e mi gonfiò
come una zampogna , Carlucci , altro ceffo da galera che cercò di mandarmi in
ospedale e ancora Piccioni, Cacchio, Coscarella
e tanti altri di cui non ricordo che il nome poi naturalmente c’era Franco
Giuffrida , l’amico del cuore.
Il primo giorno di scuola
venne accompagnato dal papà che gli chiese dove volesse sedersi, si guardò un
istante intorno poi indicò senza tentennamenti il posto vuoto accanto al mio.
Il primo banco lo si
predilige solitamente per due ragioni ben precise, o perché si è
particolarmente bravi quindi desiderosi di farsi notare dal maestro che ci
osserva dal suo piedistallo, per mostrare quel che si vale, ed era il motivo
della scelta del mio compagno,o perché si è ciechi come una talpa e da quella
distanza si intuiscono perlomeno i contorni della lavagna e questo era il mio
caso.
In quella panca di legno
nera come la pece, con quel buco al centro che mi divertivo ad imbottire di
cartacce, sede storica del superato calamaio da poco rimpiazzato dalla più
pratica penna biro, nacque giorno dopo giorno una sincera e solida amicizia che
solo vent’anni dopo cominciò a scricchiolare stritolata dalle imprevedibili combinazioni della vita.
Insieme vivemmo le più
importanti esperienze di bambini prima e di ragazzi poi, amici inseparabili
superammo i primi ostacoli della adolescenza, uniti trascorremmo gli anni
migliori a scherzare, ridere e giocare. Quanti calci al pallone, quante gioie e
delusioni d’amore confidate l’uno all’altro, quanti magici momenti condivisi.
Frequentavamo gli stessi
amici, le medesime comitive , sognavamo amori eterni, finché trovammo la
ragazza giusta e le nostre strade, fino a quel momento perfettamente parallele,
necessariamente si separarono.
Se a scuola annaspavo e , scolaro mediocre, faticavo non poco a
tenere il passo dei miei compagni , migliore
era il mio rendimento in parrocchia nell’apprendimento della dottrina cristiana .
I miei ricordi religiosi
cominciano a districarsi verso l’età dei sei anni, educato da una madre
scrupolosamente osservante che cercava d’istillarmi il gusto della cristianità
, non mi fu concesso scegliere e la
religiosità passò naturalmente dal suo seno al mio.
Verso le sei del pomeriggio
, specialmente nel periodo che va da ottobre a marzo , dopo aver
convenientemente svolto i compiti
assegnatimi dagli spietati maestri per il giorno seguente – non prendete le cose sempre così sul
serio, è solo un modo di dire – mi recavo con mamma in parrocchia per ascoltare
la messa serale e, ciondolando tra l’inginocchiatoio e il banco , seguivo rapito i gesti rituali del sacerdote
sostenendo senza apparente sforzo prima
l’interminabile rosario poi la breve funzione vespertina. Piacevolmente
inebriato dall’intenso profumo dell’incenso e delle candele accese osservavo incantato la lunga teoria dei
dipinti della via crucis che
conducevano lo sguardo verso l’altare e il grande Crocifisso collocato accanto
alla sagrestia , presso il quale sostavano in preghiera i fedeli curvi a
baciare i piedi del Cristo morente. Suggestionato dalla sacralità di
quell’ambiente finii per confidare alle mie sbalordite insegnanti di catechismo
il mio incontenibile desiderio di sacerdozio.
Mi resi tuttavia conto che
si trattava in realtà di un’infatuazione passeggera non appena, nello sciorinare il lungo elenco delle rinunce
necessarie alla vita pastorale, accennarono all’obbligo del celibato. A quel
punto la mia vocazione svanì come neve
al sole , del resto non avevo ancora capito bene la sostanziale differenza tra celibato e castità, e la mia fede
cominciò a vacillare senza tuttavia mai spegnersi completamente, un credo
insomma vissuto con profonda intensità e ferma intransigenza in un primo
momento, con accenti decisamente personali e sfumature sempre più vaporose col
passare del tempo.


